Edizione: Fortunata Latella 1994; note: Fortunata Latella. – Rialto 23.xi.2002.
D (139r); I (191v-192r); K (177rv); R (8v).
Edizioni critiche: Carl Appel, Provenzalischer Inedita aus Pariser Handschriften, Leipzig 1890, p. 305; Friedrich Witthoeft, Sirventes Joglaresc, Marburg 1891, p. 57; Fortunata Latella: I sirventesi di Garin d’Apchier e di Torcafol, edizione critica a cura di F. L., Modena 1994, p. 164.
Il v. 41 si presenta guasto nella tradizione manoscritta, che fa registrare le seguenti lezioni: pos lo paubres de bacastella R, puois los paubres batastella D, pos los baros (barons K) barestella IK. La soluzione da me prospettata rispecchia, con minimo intervento, la deposizione di R; la voce Castella indicherebbe una località dell’antico Gévaudan. Una diversa proposta di restitutio è stata avanzata da Simonetta Bianchini («BdT 443,2: Torcafol, Comunal, en rima clausa, v. 41», Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, sezione romanza, 38/2, 1996, pp. 265-268), che suggerisce di leggere lo paubre ses artella. L’emendamento non mi ha convinto per i seguenti motivi: 1) Viene congetturato un errore archetipico la cui genesi è così ricostruita (p. 270) «il copista, accortosi di aver saltato la preposizione ses, aggiunge sopra il rigo solo le due lettere es, da legare alla consonante finale di paubres, ma l’aggiunta è fatta dopo la stanghetta alta della b»; si sarebbe così creato un lo paubresbartella con es soprascritto subito dopo l’ultima -b-. Tale ipotesi però presuppone appunto ma lascia ingiustificata la presenza di una seconda -b-, che appare dal nulla, e comunque non spiega le presunte letture delle due tradizioni α lo baros barestella e β lo paubres batastella a cui farebbero capo rispettivamente IK e DR, dato che, secondo il quadro prospettato, la forma risultante dovrebbe semmai essere besartella. Si riproduce per chiarezza lo stemma delineato da Bianchini:
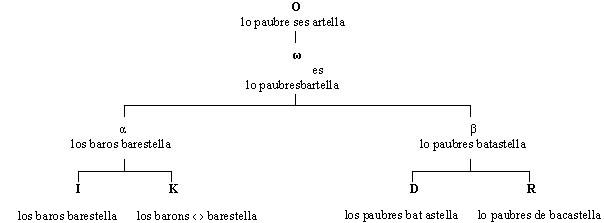
Le due distinte tradizioni avrebbero dunque concordato nell’errato inserimento del segmento soprascritto per dar per di più luogo, almeno nel caso di α, ad un termine, per ammissione della stessa studiosa, «non . . . attestato né riconducibile ad alcun lemma finora conosciuto» (p. 268). In realtà si sottovaluta il fatto che la forma astella/estella costituisce un dato omogeneo che non è lecito disattendere. 2) La forma ipotizzata artilla, di marcabruniana ascendenza (BdT 293.11, Bel m’es quan la rana chanta, v. 18), è a sua volta un lemma di dubbia esistenza, inserito in un passo dalla tradizione manoscritta tormentata. La studiosa ne propone la derivazione da una base articula con il significato traslato ‘difesa’ peraltro «non registrato nel FEW» (p. 269); gli ultimi editori di Marcabru accolgono a testo faute de mieux la voce, del solo codice R, avvertendo però che «the earliest dictionary example of OF artillerie seems to date from the fourteenth century» e che «R’s artilha may represent a fourteenth-century reading of something else» (Simon Gaunt - Ruth Harvey - Linda Paterson, Marcabru: A Critical Edition, Cambridge 2000, p. 159). Mantengo quindi le motivazioni che mi hanno spinto ad accogliere a testo la forma Castella, che a fronte di una voce solo ipotizzata e neppure sicuramente attestata all’altezza cronologica che ci riguarda (ma la ricerca è risultata infruttuosa nell’intero corpus trobadorico), rappresenta un reperto più rispettoso delle deposizioni manoscritte e designa una località reale e documentata; non costituisce ragione valida per respingerlo il fatto che il nome non venga «mai usato altrove» (Bianchini, p. 269), giacché altri toponimi nel ciclo dei due tenzonanti ricorrono solo una volta e purtuttavia esistono, come per es. Largentieira, Montfort, Lombers, Burlatz e perfino Roma!
Metrica: a7’ b8 c7’ d7’ e8 f7’ e8 e8 (Frank 869:3). Cinque coblas unissonans di otto versi ciascuna più una tornada di tre ottosillabi.